"Portavo una testa di morto" in Mordi e fuggi (Manni editore, 2007)
pag. 192 - euro 14.00 - ISBN 9788881769360
16 racconti per evadere dalla taranta
Introduzione di Marino Niola
Racconti di: Cosimo Argentina, Andrea
Bajani,
Giovanna Bandini, Giosuè Calaciura,
Antonella
Cilento, Carlo D’Amicis, Teresa De
Sio, Omar
Di Monopoli, Elisabetta Liguori, Carlo
Lucarelli,
Gianluca Morozzi, Antonio Pascale,
Aurelio
Picca, Laura Pugno, Livio Romano, Grazia
Verasani.
Il mito della taranta dato in pasto
alla
penna di 16 giovani scrittori e di
un antropologo.
Racconti dissacranti, psichedelici,
acidi,
ironici, divertenti che parlano di
una tradizione
vera, viva..
A oltre sessanta anni dagli studi antropologici
di Ernesto De Martino sul tarantismo,
il
mito legato al morso della taranta
è attuale
più che mai, tanto da spingere ogni
anno
nel Salento decine di migliaia di persone
da tutto il mondo.
16 scrittori raccontano la magia che
ancora
oggi si respira in questa regione durante
le sere ipnotizzate dal suono del tamburello,
al ritmo incessante e psichedelico
della
pizzica.
da La tarantola, di Mimmo Grasso (pubblicato
sul sito francarame.it
francarame.it/it/node/628:
: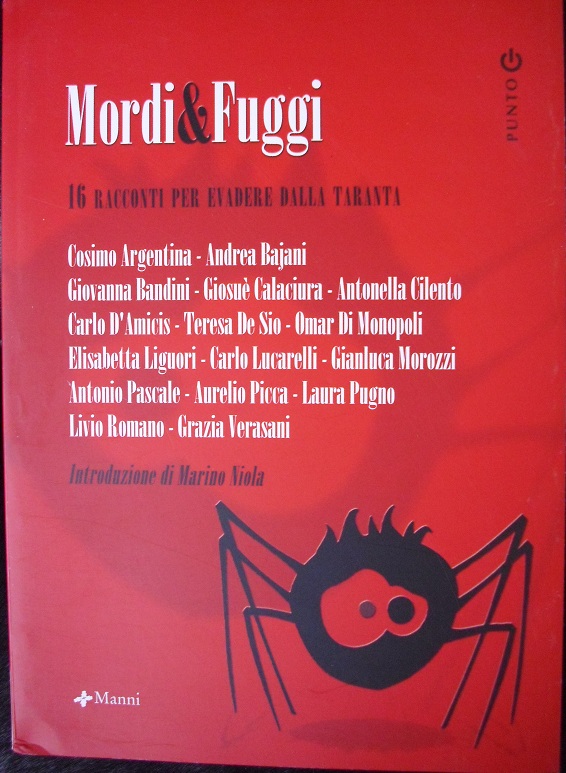
Portavo una testa di morto (Carlo Lucarelli)
La storia è questa: siamo sul finire della
seconda guerra mondiale, nel Salento. Il
narratore è un soldato che ricorda un orribile
episodio, in “preda al rimorso” . Un gruppo
di miliziani delle SS , tra cui un mongolo,
si ferma a un casolare e, dopo aver saccheggiato
, imbottiti di vino, costringono la famiglia
che l’abitava a suonare. Si intona una pizzica
che il soldato, componente della squadraccia,
riconosce. Esige che una ragazza, giovanissima,
danzi. Alla fine della danza il mongolo sgozza
la fanciulla. La casa viene bruciata. Il
narratore portava sul cappello di SS l’emblema
di un teschio.
Questo racconto è il più breve della
raccolta
ma anche il più lungo. E’ breve in
ordine
alla sinteticità e asetticità dei fatti
narrati;
è lungo in ordine alle cose implicite.
Lo spazio dove si svolge il racconto
è una
terra i cui abitanti hanno radici culturali
greche. Il tempo degli avvenimenti
è quello
della seconda guerra mondiale. Le SS
bevono
molto vino dopo essersi sedute sotto
un albero
di ulivo. Si prepara in questo modo
la scena
del delitto. Dal punto di vista simbolico,
l’inserimento della catena grecità-guerra
(intesa come orgia di distruzione)-vino-ulivo
prepara,invece , la scena del sacrificio.
Quasi di soppiatto appaiono anche altri
elementi
rituali: il pane, il coltello che il
mongolo
usava per scannare gli agnelli. Va
annotato
che il mongolo è l’unico del gruppo
a non
avere sul berretto il fregio di un
teschio
ed è l’ uomo che materialmente compie
il
delitto-sacrificio. Va altresì evidenziato
che il soldato che ricorda è una persona
molto colta: già era stato nel Salento
anni
prima per approfondire studi di storia
dell’arte.
Dunque, quello che accadrà appartiene
a una
dimensione al di là della cultura,
ancestrale,
da periodo paleolitico, quando gli
uomini
avevano i tratti somatici mongoli,
quando
a Delfi si sacrificavano persone poi
sostituite,
come nel dionisismo, da una persona
con malformazioni
(il fàrmakon) e, dopo ancora, da un
animale.
Non è, ovviamente, che si sia proceduto
a
sostituire la persona normale con quella
deforme e poi con l’animale per motivi
pietistici
o etici. Il processo è avvenuto perché
ci
si è resi conto, sulla base di nuove
analogie,
che il modo più coerente di sacrificio
a
deità terribili era quello dell’animale
a
sua volta rappresentativo dell’ antenato
teriomorfo.
Le relazioni coltello-per-gli-agnelli
e sgozzare-la-fanciulla-come-un
agnello, il vino, la musica, sono precisamente
gli ingredienti del rito arcaico.
Mi sono chiesto a lungo perché Lucarelli
avesse inserito un mongolo nel suo racconto
e perché questo mongolo uccide materialmente
la fanciulla. Ho pensato, ovviamente, al
mongolo come a qualcosa di lontano, abissale
sia geograficamente che inconsciamente. Ma
questo non spiega il perché sia proprio lui
il boia. Ho supposto che l’uccisione, lo
sporcarsi le mani sia stato delegato a un
essere ritenuto inferiore dal nazismo. Ma
neanche regge se penso a quello che hanno
fatto i nazisti. L’unico a non portare sul
berretto il teschio –mi sono detto- è lui
perché è sufficiente, per rappresentare la
morte, la sua testa (l’iconografia ci presenta
i mongoli calvi, ossuti) ma anche questa
ipotesi mi sembrava debole. La soluzione
me l’ha fatta vedere Antonio Vitolo parlando
dell’etimo di “tarantola”, che deriva da
Taras, fondatore di Taranto e che “taras”
significa “sconosciuto”. Da qui a Taras Bul
ba di Gogol’ il passo è molto breve. Sarei
comunque molto interessato a sapere dalla
testimonianza diretta di Lucarelli la funzione
di questo mongolo nel suo racconto.
La fanciulla è terrorizzata dal fregio
sulla
bustina del militare. Anche gli altri
tre
tedeschi lo portano ma è di quello
del narratore
che la fanciulla ha terrore perché
è stato
il primo che ha visto quando i soldati
hanno
fatto irruzione nella casa dove dormiva
(
portando fiaccole come nei riti arcaici).
Si tratta, anche qui, di un’apparizione
infernale
e demoniaca, come se la ragazza avesse
visto
materializzarsi l’incubo delle proprie
origini,
dei racconti intorno al fuoco, come
se la
tarantola avesse assunto sembianze
umane,
confermando clamorosamente le dicerie
sottovoce
delle anziane del paese.
E’ chiaro che la fanciulla che danza
è Proserpina
e il soldato è Ade.
Lucarelli propone, dunque, una storia
narrata
come un resoconto di cronaca e lo stile
molto
distaccato del narratore finisce per
essere
inquietante.
La vittima sembra consapevole di partecipare
a un rito forse anche atteso. Dimentica,
nel ricordo del narratore, la situazione,
la musica, la sua uccisione e, per
questo,
sopravvive. O, davanti alla visione
della
morte, sa che per cacciarla via occorre
danzare,
eseguire l’esorcismo musicale e coreutico,
ed è forse sicura che ciò che vede
non esiste,
che è in uno stato di sonno, che si
risveglierà
come si risveglia la terra.
Lucarelli non ci dice se dopo la morte
della
fanciulla la terra abbia continuato
a produrre
frutti.
Da dove traiamo questi elementi di
lettura?
Non è che ci stiamo inventando tutto?
Il
soldato “porta” una testa di morte.
Che si
tratti di un’icona cucita sul berretto
lo
apprendiamo durante la narrazione.
Astutamente,
Lucarelli , scegliendo questo titolo,
ci
dà a intendere, all’inizio, che c’è
qualcuno
che cammina con una testa di morto
sotto
il braccio, una specie di Amleto. Durante
la narrazione l’ambiguità del titolo
viene
svelata e, paradossalmente, ci accorgiamo
che veramente il soldato porta una
testa
di morto. Solo che ce l’ha sul collo
ed è
la sua, quella di migliaia di anni
fa, perché
nell’evento salentino rimosso per decenni
e ora riemerso si catapultano tutte
insieme
le dinamiche di attrazione-repulsione
per
il sangue che provava la muta di cacciatori
poi diventati soldati.
“Testa di morto” è anche il nome di
una farfalla
( è lui l’insetto del racconto) e si
sa che
la farfalla rinvia alla metempsicosi
sia
pitagorica che eleusina (Eleusi era
sacra
a Demetra, madre di Persefone).Questa
farfalla
si chiama così perché sul dorso ha
disegni
che ricordano alla nostra percezione
un teschio.
I suoi predatori vedono probabilmente
un
ragno e su questo doppio simbolismo
(farfalla-ragno)
c’è da interrogarsi trasferendolo ai
personaggi
che in tal modo interpretano un ruolo
ineluttabile
o, addirittura, indecidibile. Questo
insetto
appartiene alla famiglia delle Sphingidae
e il suo nome scientifico è Acherontia
Atropos.
Dunque non c’è solo la lontananza simbolica
della Mongolia ma anche quella dell’Egitto
e la vicinissima Grecia dionisiaca,
c’è l’Acheronte
e il flusso musicale è precisamente
l’acqua
che il soldato-Caronte fa attraversare
alla
fanciulla-Euridice. Non è allora un
“insetto”
(in-secare: gli strati del racconto
sono
di Lucarelli sono “intersecati”) che
viene
da lontano: ci è laterale, ci è vicinissimo,
a meno di un palmo ma non possiamo
toccarlo:
è la nostra psiche.
Va infine annotato che “Testa di morto”
in
lingua tedesca è totenkopf , nome della
più
bestiale divisione delle waffen SS.,
il cui
segno, lo svastica o croce uncinata,
ha radici
altrettanto arcaiche quanto la sfinge.
La fanciulla danza davanti alla morte
una
danza macabra, una di quelle danze,
cioè,
in cui nel medioevo si raffiguravano
tutti
i ceti sociali danzanti con scheletri,
specialmente
dopo la peste del 1348. Sarebbe molto
stimolante
immaginare la storia dal punto di vista
della
vittima più che del carnefice. Scopriremmo
forse che la falena che danza è la
fanciulla,
attratta dalla luce della morte.